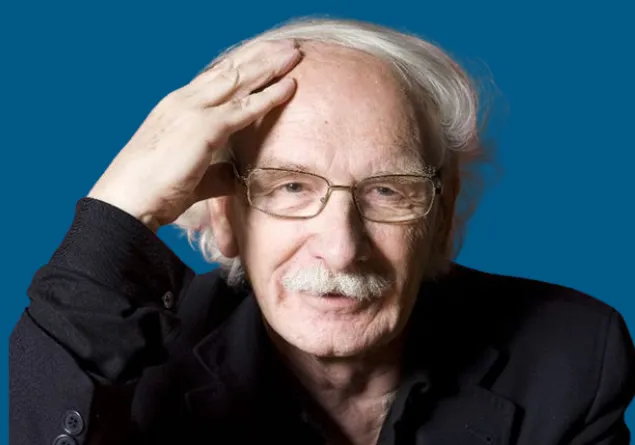
Lectio magistralis del Prof. Giacomo Rizzolatti – Congresso
Nazionale CNCP, Monterenzio, 4-5 ottobre 2025
Francesco Piomboni
1. Introduzione
La lezione del professor Giacomo Rizzolatti, figura di
riferimento mondiale nel campo delle neuroscienze, ha rappresentato uno dei
momenti più intensi e significativi del Congresso Nazionale CNCP 2025.
Il suo intervento, rigoroso e al tempo stesso profondamente
umano, ha accompagnato i presenti in un viaggio attraverso la scoperta dei
neuroni specchio e il loro ruolo nella comprensione delle azioni, delle
emozioni e delle intenzioni altrui.
L’incontro tra il sapere scientifico e la pratica relazionale
del counselling ha offerto una chiave di lettura preziosa. L’empatia come
dispositivo naturale, biologico e relazionale, capace di fondare la possibilità
stessa del dialogo um.
2. Dalla ricerca di laboratorio alla scoperta del meccanismo
specchio
Rizzolatti ha ricostruito con chiarezza il contesto originario
della scoperta: il laboratorio di Parma, negli anni Novanta, dove un gruppo di
ricercatori stava studiando la programmazione motoria nelle scimmie.
Analizzando l’attività dei neuroni dell’area premotoria F5, il
team osservò un fenomeno inatteso: alcuni neuroni si attivavano non solo quando
la scimmia compiva un’azione (come afferrare un oggetto), ma anche quando
vedeva un altro individuo compierla.
L’interpretazione di questo dato aprì una prospettiva
radicalmente nuova. Il cervello non si limitava a eseguire movimenti, ma
rappresentava internamente lo scopo dell’azione.
Era come se, osservando, la mente “ricreasse” dall’interno ciò
che vedeva, in un processo di risonanza immediata.
Da qui nacque il termine neuroni specchio, destinato a
ridefinire il modo in cui comprendiamo l’interazione umana.
L’esperimento, verificato e replicato per anni prima della
pubblicazione, rivelava che comprendere l’altro non richiede un’elaborazione
concettuale, ma un’attivazione incarnata: il corpo capisce prima della mente.
3. Il sistema specchio nell’uomo
Le successive ricerche condotte con PET e fMRI hanno confermato
la presenza, nell’uomo, di un circuito analogo a quello della scimmia.
Osservare un’azione attiva le stesse aree cerebrali coinvolte
nel compierla: il cervello umano “rispecchia” l’altro attraverso un sistema
parieto-frontale integrato.
Questa evidenza ha segnato un passaggio fondamentale: la
comprensione delle azioni e delle intenzioni non è solo un processo cognitivo,
ma un’esperienza corporea condivisa.
Rizzolatti ha mostrato come la funzione dei neuroni specchio non
sia primariamente l’imitazione — come inizialmente ipotizzato — ma la
comprensione immediata degli atti e delle intenzioni altrui.
Esperimenti condotti a Parma hanno rivelato che quando un
soggetto osserva qualcuno compiere un gesto dotato di senso (per esempio,
mordere), si attivano nel suo cervello le stesse aree motorie che entrerebbero
in azione se lo compisse egli stesso.
Viceversa, gesti privi di familiarità o appartenenti ad altre
specie vengono compresi solo per inferenza cognitiva, non per risonanza
interna.
4. Le forme di vitalità e il ruolo dell’insula
Il professor Rizzolatti ha poi introdotto il tema delle forme di
vitalità, elaborato dallo psichiatra Daniel Stern.
Ogni azione possiede non solo un contenuto (ciò che si fa) ma
una forma (il modo in cui la si compie): gentile, brusca, esitante, decisa.
Studi di neuroimaging mostrano che mentre il contenuto attiva il
circuito parieto-frontale, la forma coinvolge una regione diversa — l’insula,
sede delle sensazioni viscerali e affettive.
Immaginare o osservare un gesto “gentile” o “rude” attiva la
stessa area: il cervello distingue il tono vitale dell’azione, la sua qualità
affettiva.
Ricerche di modellazione causale dinamica (DCM) hanno
evidenziato che il circuito insula–prefrontale–premotorio–parietale si attiva
solo quando l’azione osservata è dotata di forma vitale.
È un passaggio decisivo: comprendere l’altro significa
percepirne non solo il comportamento, ma il modo di essere in azione.
5. Comprendere le intenzioni e i limiti dell’empatia
Esperimenti di elettromiografia hanno dimostrato che
l’intenzione è già codificata nel cervello durante la fase preparatoria del
gesto.
Quando osserviamo qualcuno che afferra del cibo per mangiare, si
attivano in noi i muscoli mimici corrispondenti, anticipando l’esito
dell’azione.
Nei bambini con disturbo dello spettro autistico questa
anticipazione manca: le azioni vengono percepite come frammenti isolati, non
come atti dotati di finalità.
Il deficit empatico può dunque essere letto anche come una
disfunzione del meccanismo specchio, che compromette la capacità di cogliere le
intenzioni altrui.
Ma l’empatia può essere anche sospesa: non solo per deficit
biologico, ma per costruzione ideologica.
Richiamando il caso Eichmann, Rizzolatti ha ricordato come
l’adesione a un sistema di credenze possa cancellare la risonanza con l’altro,
trasformando una persona “normale” in esecutore di violenza.
L’empatia, quindi, è una possibilità naturale ma fragile, che
può essere deformata dal contesto culturale e morale.
6. Emozioni condivise e basi neurobiologiche
Le emozioni di base — gioia, paura, disgusto, rabbia, tristezza
— possiedono una rappresentazione neurale condivisa.
Esperimenti sull’empatia emotiva hanno mostrato che osservare
qualcuno provare disgusto o ridere attiva le stesse aree che si attiverebbero
se provassimo noi quella stessa emozione.
L’insula e il cingolo anteriore, in particolare, risultano sedi
cruciali di questa partecipazione affettiva.
Si tratta di un dato di straordinaria portata: il cervello umano
è predisposto non solo a riconoscere le emozioni, ma a viverle insieme.
7. Dalla fMRI alla Stereo-EEG: comprendere la dinamica cerebrale
Rizzolatti ha illustrato anche i limiti delle tecniche di
risonanza magnetica funzionale, che offrono dati correlativi ma privi di
sequenza temporale.
La collaborazione con il centro per l’epilessia dell’Ospedale
Niguarda di Milano ha aperto una nuova fase: l’uso della Stereo-EEG, che
consente di registrare l’attività elettrica in profondità e in tempo reale.
Questa metodologia permette di osservare la dinamica temporale
delle attivazioni: come, ad esempio, l’attività somatosensoriale si propaghi
verso l’insula nei primi 200 millisecondi dopo uno stimolo, segnando il
passaggio dalla percezione fisica all’elaborazione cosciente.
8. Applicazioni cliniche: l’Action Observation Therapy
Dalla scoperta del sistema specchio sono nate applicazioni
concrete in ambito riabilitativo.
L’Action Observation Therapy (AOT) si basa sull’idea che
osservare un’azione attivi gli stessi circuiti che la compiono, facilitando il
recupero motorio.
Nei pazienti immobilizzati o operati, guardare video di movimenti
corretti accelera il recupero della mobilità.
All’Ospedale Humanitas, tale tecnica viene impiegata prima e
dopo interventi ortopedici, mentre al San Raffaele è applicata a pazienti con
Parkinson o sclerosi multipla.
L’osservazione consapevole riattiva il cervello. Vedere diventa
una forma di agire.
9. Il dialogo con il counselling
Nel confronto con la comunità CNCP, il professor Rizzolatti ha
riconosciuto la profonda affinità tra le sue scoperte e la pratica del
counselling.
Come ha ricordato il presidente Marco Deriu, il nucleo del
metodo del counsellor non risiede in una tecnica, ma nella presenza empatica
della persona davanti alla persona.
Non è una disposizione sentimentale, ma un atto professionale e
profondamente umano: un incontro in cui ciascuno riconosce l’altro come
soggetto di senso, capace di orientarsi, trasformarsi e ritrovare continuità
nella propria esperienza.
Così come l’osservazione, nel sistema dei neuroni specchio,
riattiva la memoria del gesto e la sua intenzione implicita, anche la presenza
del counsellor riaccende nel cliente la possibilità di sentire e di pensarsi in
relazione.
È una risonanza che oltrepassa il piano emotivo per farsi
processo conoscitivo: la persona, sentendosi rispecchiata, riscopre la propria
capacità di essere nel mondo.
In questa prospettiva, l’empatia non è soltanto un ponte
affettivo, ma una forma di conoscenza incarnata, una via attraverso cui la
relazione diventa esperienza di verità condivisa — il luogo in cui, come più
volte il CNCP ha sottolineato, la teoria si fa prassi e la prassi genera
sapere.
10. Conclusioni e prospettive
La lezione di Rizzolatti ha rappresentato un momento di rara
convergenza tra scienza e umanità.
Ha restituito alla comunità del counselling la consapevolezza
che la relazione d’aiuto si fonda su un meccanismo naturale di risonanza e
riconoscimento reciproco, inscritto nella nostra fisiologia.
In questa prospettiva, la scoperta dei neuroni specchio non è soltanto una pietra miliare delle neuroscienze, ma un ponte tra il sapere scientifico e la prassi educativa e relazionale.
Essa mostra, con evidenza sperimentale, ciò che il counselling
conosce nella propria esperienza: che comprendere l’altro non è un atto di
interpretazione, ma un modo di essere in relazione — una forma di presenza
capace di generare conoscenza, trasformazione e cura.